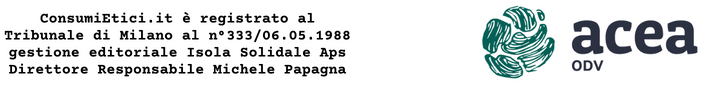QUI FUORI, NELLA STANZA
Terzo appuntamento di Segni tra il Cemento: riflessioni sull’abitare
Chiedo scusa al caso se lo chiamo necessità.
Chiedo scusa alla necessità se tuttavia mi sbaglio.
Non si arrabbi la felicità se la prendo per mia.
Mi perdonino i morti se ardono appena nella mia memoria.
Chiedo scusa al tempo per tutto il mondo che mi sfugge a ogni istante.
Chiedo scusa al vecchio amore se do la precedenza al nuovo.
Perdonatemi, guerre lontane, se porto fiori a casa.
Perdonatemi, ferite aperte, se mi pungo un dito.
Chiedo scusa a chi grida dagli abissi per il disco col minuetto.
Chiedo scusa alla gente nelle stazioni se dormo alle cinque del mattino.
Perdonami, speranza braccata, se a volte rido.
Perdonatemi, deserti, se non corro con un cucchiaio d’acqua.
E tu, falcone, da anni lo stesso, nella stessa gabbia,
immobile, con lo sguardo fisso sempre nello stesso punto,
assolvimi, anche se tu fossi un uccello impagliato.
Chiedo scusa all’albero abbattuto per le quattro gambe del tavolo.
Chiedo scusa alle grandi domande per le piccole risposte.
Verità, non prestarmi troppa attenzione.
Serietà, sii magnanima con me.
Sopporta, mistero dell’esistenza, se tiro via fili dal tuo strascico.
Non accusarmi, anima, se ti possiedo di rado.
Chiedo scusa al tutto se non posso essere ovunque.
Chiedo scusa a tutti se non so essere ognuno e ognuna.
So che finchè vivo niente mi giustifica,
perché io stessa mi sono d’ostacolo.
Non avermene, lingua, se prendo in prestito
parole patetiche, e poi fatico per farle sembrare leggere.[1]
Una lunga litania, una supplica sussurrata al mondo, mentre varchi la porta di casa. Cappello e cappotto sull’appendiabiti, vaso di ceramica, apri il rubinetto, mazzo di fiori sul davanzale. Voci alla radio, spegni la radio. Telegiornale, telecomando, spegni la tv. News, feed, post, notifiche, disconnetti. Sfogli il giornale. Vaso di ceramica, chiudi il rubinetto, mazzo di fiori sul davanzale.
La storia entrava nelle nostre case a nostro piacimento, quanto e quando lo volevamo noi. I muri delle nostre abitazioni erano una pellicola di protezione entro la quale potevamo permetterci di non far entrare polvere, caos, germi, piogge, terremoti fisici e sociali. Un tupperware di cui noi, da dentro, potevamo aprire e chiudere la valvola. La quotidianità prima che arrivasse il covid. O meglio, la quotidianità di quella ristretta cerchia di popolazione mondiale della quale, con molta probabilità, fanno parte coloro si troveranno a leggere questo articolo.
Oggi le preoccupazioni del mondo, le sue ansie, le sue frenesie, le sue meraviglie, i suoi capricci dobbiamo farceli stare tutti nella nostra (più o meno) piccola stanza, ce li portiamo addosso quando andiamo in bagno; sono sulle nostre forchette e ci entrano in bocca; dalle fibre del pigiama passano tra le nostre lenzuola. Lavoro, socialità, svago, fruizione culturale, consumo culturale, consumo e basta: tutto adesso si compie e sviluppa dentro la pellicola. Ma tracciare i confini di separazione tra pubblico e privato, tra la Storia e la mia storia, avendo come campo di azione unicamente la nostra casa, è incredibilmente più difficile di quanto non lo fosse prima dello stato di quarantena. La nostra abitazione è un sistema di vasi comunicanti dove l’acqua è arrivata ormai al colmo di tutti i contenitori.
“Forgive me, distant wars, for bringing flowers home / Perdonatemi, guerre lontane, se porto fiori a casa.”
Oltre a essere la traduzione inglese di un verso della poesia Under a certain little star (Pod jedną gwiazdką / Sotto una piccola stella) di Wisława Szymborska, questo è anche il titolo della mostra che i tre artisti iraniani Ramin e Rokni Haerizadeh e Hesam Rahmanian hanno allestito alle OGR di Torino, nel 2018 e sulla quale sono tornata volentieri a pensare negli ultimi giorni.
Una piramide di scarpe di gomma – stesso modello, forse anche stessa misura – si arrampica su una parete floreale. Decine di uomini invisibili cercano una via di fuga su per il soffitto, a carponi, l’uno sull’altro; o in un ritratto più amaro, sono coloro che sono già stati fatti uscire dalla storia, i dimenticati. Quando non è esposta in una galleria o in uno spazio espositivo, la montagna di scarpe, opera dell’artista Hassan Sharif, è allestita all’interno della casa-studio-cabinet privato dove i tre artisti coabitano e co-lavorano: non a Teheran, dove i due fratelli Haerizadeh sono nati, ma a Dubai, dove sono rifugiati dal 2009, dopo che il governo iraniano ha ritenuto di natura compromettente la loro arte e dove l’amico Hesam Rahmanian li ha raggiunti. In questa stessa casa-studio – i tre hanno costruito il loro intero universo:
“In Tehran, people place a great deal of focus on their lives indoors, so we designed our house in Iran and started a collection to surround ourselves with artworks. We have also done this here in Dubai, arranging and decorating this house together.”[2]
Una collezione composta da centinaia di opere di altri autori, molti delle quali fluxus, dialoga con i loro lavori: ritagli del mondo esterno – dai giornali, dalla tv – sui quali gli artisti sono intervenuti in diverse forme. Sono arredi d’uso quotidiano, oggetti privati ai quali il gesto artistico strappa una battuta di attualità sociale. Nella loro casa, una bocca dentata urla dallo schienale di una sedia, impedendo a chi lo voglia di appoggiarvisi comodamente. I ritratti di famiglia appesi alle pareti hanno volti senza occhi, o dalle sembianze zoomorfe. Sono creature fiabesche e mostruose, membri di quella famiglia allargata alla quali gli artisti sentono di appartenere. Quell’umanità che con disperata ironia veste ogni giorno il costume di giullare di corte, di servo: i migranti, protagonisti dei grandi esodi verso l’Europa, in fuga dalle guerre del sud e dell’est del mondo. Intanto la regina d’Inghilterra ci sorride sorniona dal fondo di un piatto di porcellana fattosi texture per carta da parati.
Le mostre del collettivo sono sempre grandi scenografie attraversabili, che riproducono l’universo eclettico della loro abitazione e che si sviluppano e ampliano grazie all’inarrestabile azione del dastgah. In persiano questa parola significa macchina, dispositivo, ma si riferisce anche a un sistema modale della musica tradizionale persiana. Per i tre artisti, farsi dastgah significa farsi macchina pittorica: spesso ciò che si vede in mostra è il frutto di processo performativo lungo e finemente progettato, dove gli artisti, in costume, eseguono a ciclo continuo una partitura di azioni definite, inseguendo le poche variabili aperte. Così nell’opera The Maids, proprio come nella pièce di Jenet cui s’ispira, attraverso un’improvvisazione di giorni sulla partitura prestabilita, hanno esplorato il confine tra l’essere serve e padrone. Le vediamo in un video, a pulire la stanza, spostare gli arredi, misurando continuamente i rapporti di forza e i giochi d’attrazione tra loro, all’interno di un set, che è anche lo stesso ambiente dal quale lo spettatore guarda il video. Un continuo gioco di scatole cinesi, non c’è un dentro o un fuori la scena. Lo spettatore è nella scena.
Proprio come nella condizione attuale in cui ci troviamo, siamo sempre in scena a giocare ogni ruolo della nostra vita, all’interno dello stesso set: siamo genitori, figli, lavoratori, amici, volontari, attivisti, amanti, atleti, artisti, contemporaneamente. E quando questo non è possibile, le nostre identità più fragili, forse le più preziose, vengono soppresse. Gli unici confini in questa dimensione sono dettati dal comportamento che decidiamo di assumere, dai binari che ci auto-imponiamo, da una disciplina del gesto e dello sguardo che ci permetta di non confonderci, di non fare che tutto assuma lo stesso sapore e soprattutto ci permetta di eludere il rischio più grande: abituarci, dare per scontato.
“Ti prego, morte, non lasciarti addomesticare, continua a farmi assoluto male” [3]
I tre artisti – amici e fratelli – abitano insieme, lavorano insieme, fanno attivismo insieme, in un engagement totalizzante. Ma attraverso un processo fatto di regole autoimposte e di una determinante dose di ironia Ramin Haerizadeh, Rokni Haerizadeh e Hesam Rahmanian riescono a vivere la loro quotidianità, senza svestirsi dell’abito dell’artista. Come le creature che popolano i loro disegni, un po’ locuste, un po’ bachi da seta, divorano con metodica voracità tutto ciò che si trovano appresso, per poi trasformarlo in fili di seta. Decidono se essere serve o padrone continuamente, rinnovando a ogni istante della loro vita la scelta. Essere artisti vuol dire abitare il proprio ruolo sociale, costantemente, e può essere sfiancante.
Paura
Nello spazio delle OGR, una grossa medusa di tessuto bianco appesa a una parete, apre di tanto in tanto la sua ampia veste di tentacoli, mostrando delicatissimi ricami, prima nascosti. Si apre però ogni qualvolta la sua preda è distratta, tanto lontana da non aspettarsi alcun movimento dalla macchina zoomorfa, tanto vicina da sentirsene affetta. La medusa è un dispositivo della paura, un’ombra che abbraccia, di una bellezza maestosa e temibile. Lo spettatore attento sa che l’azione della medusa avviene in reazione al suo movimento, sa che sono il suo comportamento e pensiero a influenzare l’emersione della paura, ma non capisce esattamente in che modo influiscano, né come controllarli. I tre artisti ci invitano a portare la paura dentro casa, collocarla in salotto o in sala da pranzo, in camera da letto. Là dove, in convivenza forzata, giorno dopo giorno, con la paura possiamo stringere una relazione e godere almeno della sua disarmante eleganza.
Oggi la storia, sotto forma di paura, entra nella nostra stanza, perché il nemico è potenzialmente ognuno di noi. Così come ci ritroviamo giocare ogni ruolo della nostra storia individuale, non possiamo evitare di vestire anche un ruolo nella scena collettiva: siamo necessariamente l’antagonista, o l’eroe, o l’aiutante dell’eroe. Anche comodamente da casa nostra, lo spazio che normalmente consideriamo un fuoriscena.
Ma quello di poterci sentire chiamati fuori, l’avere un fuoriscena, è un privilegio che siamo abituati a pensare come diritto. Ci sono milioni di stanze senza pareti, là – qui – fuori. Oggi proviamo tutti quello che un’enorme fetta di popolazione mondiale prova ogni giorno: quelli che ogni giorno si portano sulle spalle il loro carico di storia e lo agiscono, volenti o nolenti, con i tempi e le modalità che qualcun altro gli impone. Coloro che non hanno accesso a una dimensione privata, che non possono permettersi di disegnare una propria routine. Persone obbligate a portare il loro destino – fragilissimo – sul polpastrello dell’indice; coloro per i quali la massima aspirazione abitativa è un foglio di carta con un indirizzo di residenza, che li legittima a stare. Chi non ha una casa fisica, ha casa nella storia.
Come tutti anche io in questi giorni di quarantena mi confronto con amici, colleghi e parenti e tanti, io per prima, sembriamo accusare un malessere non localizzato, un senso di impotenza e angoscia. Notiamo con imbarazzo l’inadeguatezza e inappropriatezza di cui si colorano tutte le nostre azioni quotidiane, nello scenario disastroso collettivo. Non siamo abituati a tenere sempre attaccata la spina dalla nostra responsabilità individuale. Dall’arte impariamo che abitare vuol dire avere un palco, un set, uno spazio espositivo, un ambiente entro il quale poter esercitare il controllo delle nostre azioni. Entro il quale disegnare la nostra posizione, tracciare delle routine. Costruire delle prassi di relazione con ciò che accade nel resto del mondo e con la paura che spesso ne governa la cronaca.
Ma dall’arte impariamo anche che queste routine possono essere fatte di bellezza e ironia. Impariamo che nella leggerezza non c’è colpa quando c’è presenza. Impariamo che anche nel sonno, nella dimenticanza, nel riposo, quando ascoltiamo il disco con il minuetto, quando portiamo a casa un mazzo di fiori, siamo agenti della storia in prima persona: in quei momenti siamo agenti di quel riposo e di quella dolcezza per tutti e con tutti. Chiamarsi fuori è un abbandonarsi alla paura, rinunciando a conoscerla. Saper creare invece una partitura, all’interno della quale ogni variazione, ogni pausa e ogni momento di bellezza, partecipa del componimento nel suo insieme: anche questo, forse, vuol dire abitare.
[1] Wislawa Szymborska, Sotto una piccola stella, da “Ogni caso” (1972), in “La gioia di scrivere – Tutte le poesie” (1945-2009), Adelphi, trad. di Pietro Marchesani.
[2] http://artasiapacific.com/Magazine/89/RaminRokniHaerizadehHesamRahmanian
[3] Chandra Livia Candiani, Il Silenzio è cosa viva. L’arte della meditazione, Einaudi, Torino 2018. Grazie a Anna Stefi per avermi ricordato la citazione: https://www.doppiozero.com/materiali/diario-di-uninsegnante-line
Emirati conceptual artist Hassan Sharif’s mountain of shoes, displayed in the living room, stands out among the Haerizadeh brothers’ private collection. Photo by Farah al-Qasimi for Art Asia Pacific
Ramin Haerizadeh, Rokni Haerizadeh, Hesam Rahmanian. Forgive me, distant wars, for bringing flowers. Installation view at OGR, Torino 2018. Photo Andrea Rossetti
Ramin Haerizadeh, Rokni Haerizadeh, Hesam Rahmanian, From Sea to Dawn, 2016, Single channel colour video (rotoscopy), no sound, 6 minutes and 21 seconds,Courtesy of Gallery Isabelle van den Eynde
Ramin Haerizadeh, Rokni Haerizadeh, Hesam Rahmanian, Installation. Courtesy of Gallery Isabelle van den Eynde
Ramin Haerizadeh, Rokni Haerizadeh, Hesam Rahmanian – Forgive me, distant wars, for bringing flowers home a cura di Abaseh Mirvali – OGR, Torino, Installation view – Photo Andrea Rossetti
Ramin Haerizadeh, Rokni Haerizadeh, Hesam Rahmanian – Forgive me, distant wars, for bringing flowers home a cura di Abaseh Mirvali – OGR, Torino, Installation view – Photo Andrea Rossetti
Ramin Haerizadeh, Rokni Haerizadeh and Hesam Rahmanian
The Maids, 2012-
Single channel colour slideshow video, no sound
18 minutes and 33 seconds
Courtesy Gallery Isabelle Van Den Eynde
Ramin Haerizadeh, Rokni Haerizadeh, Hesam Rahmanian
Royal Goose, 2017
Collage, binder, gouache, watercolor, gesso, acrylic on paper. Courtesy Galerie In Situ Paris
Ramin Haerizadeh, Rokni Haerizadeh and Hesam Rahmanian, Where is Waldo, 2009, paper collage, acrylic, watercolor, ink, gesso and gouache on paper. Photo: Tamara Rametsteiner
Courtesy Galerie Krinzinger, Vienna
Ramin Haerizadeh, Rokni Haerizadeh, Hesam Rahmanian, The Maids, 2012–17, Single channel colour slideshow video, no sound
18 minutes and 33 seconds
Ramin Haerizadeh, Rokni Haerizadeh, Hesam Rahmanian – Forgive me, distant wars, for bringing flowers home a cura di Abaseh Mirvali – OGR, Torino, Installation view – Photo Andrea Rossetti
Ramin Haerizadeh, Rokni Haerizadeh, Hesam Rahmanian – Forgive me, distant wars, for bringing flowers home a cura di Abaseh Mirvali – OGR, Torino, Installation view – Photo Andrea Rossetti