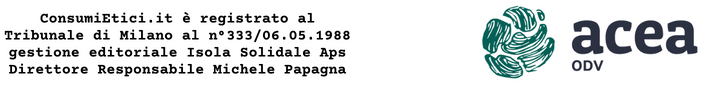Siamo consapevoli della drammaticità di un’epidemia in Africa?
Da una parte c’è un’Europa che intesse accordi internazionali per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, ci sono gli Stati Uniti arresisi ormai all’evidenza di doversi piegare alle necessità di contenimento a protezione del proprio paese, c’è la Cina con la sua lotta interna al Covid-19 verso un ritorno alla normalità: dall’altra parte c’è l’Africa, un continente terrorizzato dall’avanzare della pandemia e dalle misure di contenimento che verranno applicate.
È difficile capire come le stesse misure prese nei nostri paesi influirebbero sulla vita nel continente africano: ciò che a noi viene chiesto da questa parte del mondo è di rispettare il distanziamento sociale, il “sacrificio” così chiamato da molti di restare al sicuro nelle proprie case, di rinunciare alla scuola tra i banchi a favore dell’educazione online portata avanti nonostante il divario digitale notoriamente presente in Italia. È richiesto di rinunciare alla nostra quotidianità che sta portando difficoltà a molti in termini economici, ma anche a livello psicologico. È richiesta la rinuncia alla nostra realtà così come la conosciamo, per un po’. Eppure, resteremo nelle nostre case robuste, continueremo a guardare scorrere le notizie in televisione, a distrarci nei mille modi possibili che una vita in casa offre, saremo un po’ più soli, ma saremo capaci di esserlo. Non è una colpa, ma si potrebbe utilizzare parte di quel tempo per volgere lo sguardo oltre il proprio uscio, e ascoltare e comprendere realmente le parole di chi non è solo osservatore esterno, ma è in grado di fornirci una visione dall’interno di un paese in estrema difficoltà.
Se all’inizio della pandemia l’Africa sembrava riuscisse a rimanere indietro rispetto ai contagi che si susseguivano nel resto del mondo, ora i numeri riportati dall’Africa Center for Disease Control on Covid-19 parlano di una scia di contagi che aumenta esponenzialmente: su 55 stati, sono 52 quelli ad averne registrato, e l’ultimo aggiornamento riporta un totale di 13.686 casi e 744 morti.
Con il registrarsi dei primi casi, è aumentato anche il senso di impotenza, il sentimento di paura giustificata in un paese che pochi giorni fa è stato colpito dalle parole di Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore dell’organizzazione mondiale della sanità che affermava: “l’Africa deve prepararsi al peggio”, rimarcando durante la conferenza a Ginevra come il continente debba svegliarsi. Nelle parole di Guglielmo Micucci, Direttore di Amref Health Africa in Italia, un’ulteriore conferma della preoccupante situazione africana “I sistemi sanitari della maggior parte dei Paesi africani sono fragili e le strutture non sono adeguatamente attrezzate per far fronte ad una pandemia di questa portata, inoltre, le infezioni respiratorie – quelle che colpiscono le vie aree e i polmoni – sono la causa principale di morte nel continente africano. Le malattie più comuni dovute a queste infezioni sono la bronchite e la polmonite, malattie che condividono i sintomi con Covid-19, quindi non è facile distinguere i casi “normali” di decessi per polmonite dai casi di decessi legati a Covid-19. Il monitoraggio, la sorveglianza e la diagnosi, in questo modo, diventano ancora più difficili”.
Non solo la diagnosi risulterà difficile, ma anche e soprattutto il tentativo di garantire un luogo sicuro che favorisca l’isolamento nelle proprie case e mitighi il diffondersi dei contagi. Perché? Nelle parole di padre Renato Kizito Sesana, missionario e giornalista che dal 1988 vive e opera in Kenya, spontanee le domande: “Restare a casa? Quale casa? Forse una stanza dove la sera si mettono coperte per terra perché ci siano abbastanza spazio per stare tutti sdraiati. Servizi in comune. Acqua alla fontana. Se chiuderanno le scuole dove andranno i bambini?”
Facendo un passo indietro è utile osservare il cambio di scenario avvenuto in Africa, le sensazioni mutate, la consapevolezza della pandemia mondiale che è possibile descrivere grazie alle parole di un nostro collaboratore che si trovava nella capitale guineiana prima dell’insorgere della pandemia: Gian Marco, partito per Conakry a metà febbraio a seguito di un progetto dell’associazione Altropallone in parternariato con Accademy Football Madarom Guinee, racconta che al suo arrivo l’informazione sul virus era già diffusa, sebbene mancasse il senso di globalità e rimanesse un virus europeo. Italiano più precisamente: com’è stato più volte definito era “il virus che viaggia in prima classe”. Il sentimento iniziale verso gli operatori volontari che si erano recati in Guinea a favore del progetto era quasi di ammirazione “sembrava colpire il fatto che io fossi li nonostante in Italia si diffondesse l’emergenza”.
Sul falso senso di sicurezza e sull’idea che non si trattasse di un pericolo imminente, vi è da considerare che la Guinea essendo un paese francofono e subendo tuttora l’influenza per quanto riguarda i mezzi di comunicazione dei canali e notiziari francesi, ed essendo che la Francia non era ritenuta ancora paese a rischio a febbraio, a maggior ragione veniva visto questo problema come distante. Quando poi Macron ha fatto un passo indietro, optando per la chiusura delle scuole, il distanziamento sociale e richiamando l’unità nazionale, ecco giungere la dolorosa consapevolezza di non essere più al sicuro. Di lì a poco con i primi casi confermati sul suolo africano, giungevano le parole delle istituzioni.
In quei giorni Gian Marco, a quel punto bloccato in Guinea per l’improvvisa cancellazione dei voli internazionali e problemi nel rinnovo del visto, ha visto il progredire del problema che dall’informazione mediale si concretizzava nella realtà, con il primo caso registrato venerdì 13 marzo in Guinea: “questo ha cambiato molte cose, si sono subito mostrati molto preoccupati. Soprattutto perché il primo caso è stato ricondotto a un medico europeo belga che lavora per l’Onu e che dopo un soggiorno in Europa al suo rientro è stato testato positivo al virus: questo ha fatto emergere paura nei confronti degli expat, degli europei che lavorano in Africa perché sono consapevoli di non essere pronti a gestire un’emergenza. Non hanno una sanità come la nostra che gli permetterebbe di curare i malati e hanno un tasso di contagio molto più alto vivendo in realtà molto affollate con pochissime norme igieniche, “supermercati” in cui le misure a scaglioni sono utopia. La vita è per strada, è tutto nel mercato dove il contatto fisico è inevitabile in una città caotica come Conakri”.
Ad affermarlo anche padre Renato Kizito Sesana dal Kenya che si domanda “Se non potrai restare in strada, come farai?”. I volontari presenti sul territorio sono alla ricerca di una soluzione in collaborazione con il governo, per evitare che soprattutto i minori restino senza un punto di riferimento sul territorio, in particolare “per preparare un intervento con i bambini che sono stanziati in centro città e sono i più a rischio”. Intanto le misure di contenimento avanzano attraverso l’istituzione del coprifuoco, non esente da proteste, che porta a generare misure ancora più restrittive.
Le misure richieste rischiano però di far degenerare la situazione specie in città come Nairobi, una delle capitali africane più sviluppate, più occidentali dal punto di vista di infrastrutture, grattacieli, uffici, ma che conserva le contraddizioni tipiche dell’Africa in quanto figura anche come la città con il maggior numero di slums, ovvero baraccopoli: “è una realtà estremamente povera, affollata – racconta il nostro collaboratore Gian Marco – dove decine di migliaia di persone vivono in case fatte di lamiera di una decina di metri quadri senza nessun servizio igienico. Sono tutti all’aperto in mezzo alla strada dove si creano questi rigagnoli di urina e feci e dove il livello di contagio è altissimo, inimmaginabile. Quindi il fatto che i bambini invece che andare a scuola saranno costretti a rimanere a casa, considerando casa un posto di 5 metri quadrati in cui vivono in sei persone e che che per questo la vita non si svolge mai nelle case in Africa, è impossibile pensare di porre le stesse misure europee, è inapplicabile perché non esistono le condizioni idonee, quindi potrebbe essere un disastro”.
Testimonianze che aiutano a comprendere le difficoltà di un paese notoriamente povero, ma che risulta purtroppo ancora incomprensibile a quanti ignorano l’esistenza di una realtà apparentemente lontana. Le difficoltà e le sfide si moltiplicano, specie per chi non ha un posto dove andare, per chi considera la strada il proprio posto sicuro, ma che ha bisogno di punti di riferimento solidi come le associazioni e i volontari presenti in loco tentano quotidianamente di dare.
La drammaticità della situazione è facilmente riassumibile nelle parole di Daniele Sciuto, responsabile della task force istituita per affrontare l’emergenza nella regione del Samburu in Kenya: “Due giorni fa abbiamo messo un punto acqua all’ingresso dell’ospedale per lavarsi le mani prima di entrare ma è finito subito perché la gente veniva per berla”. Una frase che colpisce profondamente ma che è difficile sentire sulla propria pelle e avere il coraggio di comprendere cosa sia difficile, diverso, cosa sia una sfida al di fuori della nostra percezione della realtà conosciuta. Ma serve il coraggio dei tanti che con il loro operato concreto, ci possono mostrare senza mezzi termini il significato di sacrificio e di quanto una realtà possa essere molto più drammatica di quella che conosciamo. L’appello per questi paesi è di chiudere gli aeroporti, di lasciar fuori i turisti perché potrebbe davvero creare una strage inimmaginabile.
Per concludere ancora con le parole di padre Renato Kizito Sesana: “Siamo tutti sulla stessa barca. Anche se alcuni hanno i remi, e altri no.”
Alice Cubeddu