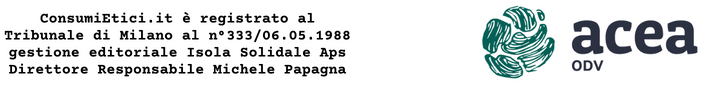“Apro il giornale, lo scorro rapidamente e capisco subito che mi espongo al contagio, poiché la paura, come si dice, è contagiosa”
Marc Augè, Le Nuove Paure 2013
Le righe che seguono rappresentano alcuni appunti, solo leggermente rimaneggiati, da me presi nel corso di queste strane notti di quarantena. Hanno tutti a che fare con la comune matrice del concetto di “contagio” e provano a descrivere le diverse dimensioni trasformative che il potere di questa categoria esercita sull’esperienza reale.
Invidio molto le decine di giornalisti, pensatori e esperti che in questi giorni leggo avidamente. Li invidio perché sembrano sempre avere le parole giuste per spiegare ciò che alle mie capacità analitiche appare estremamente confuso. Dall’altro lato penso però che solo il tempo consentirà a tutti di avere una visione più lucida e puntuale degli avvenimenti che si susseguono uno dopo l’altro in maniera così frenetica. Forse è una delle cosiddette “deformazioni professionali”. Per me che ho studiato antropologia il tempo è realmente una dimensione fondamentale. Un’etnografia richiede di stare, di esserci, di costruire lentamente giorno per giorno il proprio campo. Tutto ciò che segue infatti non pretende di essere una tesi a cui guardare con ammirazione per spiegare ciò che sta attraversando la nostra quotidianità. Sono semplicemente pensieri, piccoli spunti, attrezzi disordinati di una cassetta che richiede ancora molto lavoro di sistemazione come forse direbbe Wittgenstein. Spero che il lettore sia clemente nel perdonare eventuali imprecisioni ed errori concettuali. Il tono delle seguenti righe ha certamente più il sapore del dubbio che della certezza.
Contagio. Il contagio appare in questo momento più che mai come una categoria ricca di significati. Questo vale non solo per il valore che essa assume in quanto concetto ma in particolare per la sua capacità di agire concretamente determinando una catena di trasformazioni dell’esperienza umana.
Una categoria densa di significati che Frazer ne “Il Ramo d’Oro”, sua più celebre opera, sostiene essere uno dei due principi cardine, accanto a quello analogico, su cui si innesta lo stesso pensiero magico (Frazer, 1911-15). Tralasciando il fondo marcatamente evoluzionista della teoria di Frazer, appare chiaro come il contagio sia da sempre al centro delle riflessioni delle comunità. La diffusione di una malattia è parte integrante dell’esperienza umana, appartiene a quel livello di eventi che nel corso della storia e in maniera sempre differente è stato fortemente simbolizzato, ritualizzato e discusso al fine di comprenderlo e renderlo intellegibile attraverso la forza del pensiero umano. A volte il contagio è posto in diretta connessione con la categoria di “peccato”, come accade spesso nella mitologia cristiana. Altre volte è frutto dell’ira/favore divino, come accade in Omero. Tra i Guajaro descritti da Perrin il contagio è regolato da principi di contaminazione che hanno tutti a che fare con l’idea di contatto con sostanze specifiche e ben definite: gli animali, le ossa di un uomo morto, il corpo di un uomo assassinato (Perrin, 1985). In altri casi, anche a noi più vicini, l’essere contagiati va spesso di pari passo con la “trasgressione”, il contravvenire a certe norme sociali. Si pensi ad esempio alla diffusione dell’Aids la cui trasmissione è spesso individuata nella colpa soggettiva e nell’infrazione delle “buone norme”. In tutti i casi mi sembra che un aspetto comune del contagio stia soprattutto nella sua capacità di trasformare ciò che ci circonda.
È al potenziale trasformativo del contagio che vorrei ricondurre gli appunti qui sparsi.
Gesti. Tutto comincia così. Il contatto, l’incontro, la relazione, la parola, un abbraccio, una stretta di mano, un bacio. Simboli di umanità che tutto a un tratto da comportamenti quotidiani necessari e fortemente costitutivi delle nostre identità si trasformano in vettore di sofferenza, malattia. Tutto comincia così. Con la trasmutazione di gesti pratici e simbolici così scontati e “naturali” in eventi di trasmissione pandemica. Se il contagio è veloce, fulmineo, come lo è per Covid-19, la rinuncia a questi comportamenti fatica ad esserlo. Questa prima trasformazione non è immediata, richiede tempo perché la si comprenda e la si prenda sul serio. Perché la rinuncia, l’alterazione, persino la “criminalizzazione” di questi comportamenti che costituiscono la base del vivere comune costruito in secoli di storia è così difficile da accettare che ha dell’incredibile. Questo quanto meno accadeva quando il virus ci sembrava così lontano ad oriente e fino a pochi istanti prima che la trasformazione fosse completa anche qui. I gesti si trasformano e assumono nuovi significati. Non solo i gesti ma anche gli elementi e le relazioni che quotidianamente viviamo sono costretti a riformularsi alla luce dell’epidemia. Privandoci della libertà di movimento una quarantena trasforma il senso che diamo alla nostra casa, alle nostre amicizie e affetti, ai nostri modi di comunicare, ai nostri valori e contemporaneamente ci impone di rivedere anche i significati del mondo che sta fuori.
Il valore della comunità si modifica radicalmente. Nell’isolamento si fa grande la necessità di ritornare a pensare in termini comunitari, fuori dalle retoriche e dagli hashtag. Gli eventi recenti ci dimostrano quotidianamente, tra menefreghismi e caccia alle streghe, che una comunità non esiste se non all’interno di una dimensione ormai ridotta all’osso. Il contagio diventa così un potenziale strumento per ripensare la società quasi da capo, tornare la fuori per ricostruire una communitas, detto con le parole di Victor Turner.
Distanze. La velocità del contagio ci racconta di quanto il mondo contemporaneo sia interconnesso, interdipendente. Il virus si sposta letteralmente alla velocità del mondo globale seguendo le rotte del commercio, del turismo, dell’economia fino a penetrare nelle reti più intime della nostra vita nella famiglia per esempio. Ma questo aspetto dei contagi, in realtà, lo si conosce da sempre. Le maggiori epidemie della storia sono nate proprio da queste interconnessioni mostrando come «siamo sempre stati globali», parafrasando Ugo Fabietti. È il ritmo con cui l’epidemia si manifesta a costituire il dato di novità. La compressione temporale operata dalla rapidità del contagio fa sembrare distanze apparentemente incolmabili così vicine tanto da sbalordire, lasciare attoniti, sorpresi e impreparati. Una settimana il virus è in Cina e tutto sembra così lontano. È il tempo dell’indifferenza, del cinismo e dei biechi episodi razzisti che oggi, quando la Cina è sulla bocca di tutti anche per i gesti di solidarietà compiuti verso il nostro paese (di cui potremmo discutere a lungo), sembrano completamente dimenticati. Trasformare le distanze: ecco un altro potere del contagio. Svelare e mettere in mostra il sistema linfatico di un sistema mondo che non può fare a meno di essere interconnesso, indipendentemente da ciò che pensano i sostenitori dei muri. Curioso a questo proposito che il virus odierno non si sia diffuso seguendo le rotte della disperazione. Al contrario il contagio ha preferito seguire “canali preferenziali” più rapidi, ricchi e insospettabili.
Qui le epidemie arrivano dove altre categorie dell’emergenza non sono mai riuscite ad arrivare. Il cambiamento climatico ad esempio è uno degli elementi di crisi globale più dibattuti oggi. È anche il più “certo”, il più scientificamente incontestabile e uno dei fattori di rischio maggiori della contemporaneità. È la crisi più grande ma è anche quella per cui abbiamo soluzioni certe verso cui dirigerci. Per il clima abbiamo una cura (e le mappe riguardanti la riduzione dell’inquinamento atmosferico osservato in parallelo alla chiusura delle attività sono il perfetto esempio per confermarla) per il virus ad oggi no. Eppure il cambiamento ambientale non esprime lo stesso potenziale di contagio, la stessa forza trasformatrice di abitudini e distanze.
Rischio. La percezione socialmente costruita del rischio, insieme alle altrettanto socialmente costruite forme di diniego entrano fortemente in gioco in questa terza trasformazione prodotta dal contagio. Numerosi contributi etnografici hanno saputo dimostrare come le categorie di “rischio” e “pericolo” insieme alle rispettive forme di rifiuto affondino sempre le radici all’interno di un contesto sociale da cui traggono linfa (Norgaard, 2011; Lakoff, 2019). Il nostro modo di percepire e interpretare un rischio è infatti un prodotto operativo di un insieme di fattori tutti molto culturali e socialmente determinati: abitudini, mezzi di informazione, linguaggio, emozioni, consuetudine all’esposizione, conoscenza e categorie di “purezza/pericolo” (Doughlas, 1975). Tutti questi elementi collimano,anche nelle vicende legate all’attuale pandemia quando, con la stessa rapidità di un battito di ciglia, il rischio del contagio passa dall’essere impercepibile e lontano a divenire priorità nella nostra scala della percezione del pericolo. La sua forza trasformativa è tale che riesce quasi a spazzare via altre paure che per un attimo richiudiamo in un cassetto.
Nell’emergenza odierna gran parte della trasformazione che il contagio opera sulla percezione del rischio si gioca soprattutto all’interno del dominio linguistico. Non solo infatti la nostra mancanza di consuetudine a crisi sanitarie estreme ha contribuito inizialmente alla sottovalutazione del rischio e ha offuscato la nostra percezione dell’intero sistema sanitario nazionale, palesemente impreparato ad affrontare questa minaccia fantasma per una serie di ragioni che sono costretto qui a sintetizzare con il termine “neoliberismo”. Il linguaggio con cui si sceglie di affrontare il contagio produce inevitabilmente l’attivazione di un campanello di allarme. Proprio mentre scrivo viene pubblicato sull’Internazionale un articolo che spiega molto bene questo punto. In sintesi è naturale osservare come le narrazioni politiche, mediatiche e degli organi istituzionali sia intriso di metafore comunicative per discutere il contagio. L’epidemia diventa alle volte oggetto di un vocabolario statistico mentre nella maggior parte dei casi assistiamo a metafore di natura emergenziale, soprattutto bellica. Bollettini quotidiani, vittime, fronte, esercito, combattere, proteggere, difendere. Sono tutte parole che ritornano spesso all’interno dei comunicati ufficiali del Governo e delle Istituzioni. La mia opinione, seguendo un recente contributo di Andrew Lakoff pubblicato nella raccolta The Anthropology Of Epidemics edita solo pochi mesi fa da Routledge, è che queste metafore linguistiche siano necessarie all’assimilazione di uno specifico evento, catastrofico, difficile da comprendere e domare, all’interno di una cornice più generale e soprattutto più familiare. Una dichiarazione di emergenza nazionale trasforma un fenomeno minaccioso e incognito in un evento maggiormente comprensibile e potenzialmente gestibile attraverso risorse, strategie e narrative più comuni e vicine all’esperienza. Il contagio non è più un problema legato al diffondersi di una malattia infettiva, diventa questione amministrabile e gestibile attraverso gli strumenti che le metafore belliche ci consentono di mettere in campo inserendola all’interno di una cornice preesistente. Lakoff dimostra molto bene questo aspetto occupandosi di una recente epidemia, quella del virus Zika diffusosi in Brasile nel 2015. L’invito è quello di rintracciare l’articolo dell’autore che trovo estremamente illuminante rispetto agli eventi odierni.
Corpi. L’ultima trasformazione su cui vorrei riflettere è quella che pone in diretta connessione il contagio con il corpo o meglio, con i corpi. Perché i corpi non sono solo molti in termini di statistiche riguardanti la diffusione della malattia. L’antropologia medica, attraverso l’attività etnografica, ha spesso ricordato come le nozioni di “corpo”, “salute” e della stessa “malattia” agiscano materialmente e simbolicamente sui corpi viventi e in quanto tali sono inseparabile dai campi sociali e dalle forze storiche che li interessano (Pizza, 2010).
All’interno di questo campo di forze sociali mi sembra che la prima trasformazione del corpo soggettivo si quella che trasforma gli individui, i malati, in pure quantità. La soggettività e l’identità sociale, politica e culturale del contagiato vengono completamente soppresse all’interno di una metamorfosi che fa del corpo sofferente un numero (quanti morti, quanti guariti), un dato anagrafico (quanto anziano), una cartella clinica (quanto era già malato).
Il corpo così oltre che potenziale vettore della malattia diventa sintesi ultima della scienza epidemica. Un corpo solo a tu per tu con la propria sofferenza e colpito da una malattia in grado di privarne la parola insieme alle metafore per esprimere il proprio dolore, fino a privarne del respiro. Il modus operandi con cui questo virus agisce sottrae il soggetto dalla possibilità di essere ascoltato, accolto, compreso. Viene meno la possibilità di comunicare la propria sofferenza e di condividerla socialmente lasciando il corpo malato in una pure condizione di disease (Kleinmann, Good, 1989). Questo vale certamente per le forme più gravi in cui la malattia si manifesta ma, contemporaneamente colpisce anche coloro che manifestano sintomi più lievi. Isolati per paura che inneschino altre catene di contagio, soli per la maggior parte del proprio tempo con le proprie paure e incertezze.
Il contagio trasforma il corpo nella “nuda vita” di Agamben (molto criticato in questi giorni per alcuni suoi forti contributi sul sito della casa editrice Quodlibet), un soggetto privato della possibilità di essere tale e ricondotto al solo esercizio delle sue funzioni biologiche. Così come vicino alla nuda vita arriva a sembrare il corpo sano nella quarantena. Isolato e privato dei legami sociali che lo rendono più di un essere biologico. La quarantena è un bene necessario, ma occorre ricordare che non tutti possono viverla e affrontarla con le fortune di chi per esempio vi scrive. Case minuscole sprofondate nelle brutture delle periferie urbane, categorie fragili, poveri, senzatetto o migranti. Corpi per i quali se già la normalità assegna a loro il solo esercizio della nuda vita, la quarantena può apparire l’inferno. In parallelo inoltre il corpo sano del nostro vicino, il corpo di colui che considero “amico” a questo punto si trasforma, nel contagio, in qualcosa di sorprendentemente perturbante, una potenziale minaccia da esorcizzare con una battuta che lascia l’amaro in bocca e una strana nostalgia.
I corpi soggettivi, all’interno del paradigma dell’emergenza, vanno in contro alla spersonalizzazione per materializzarsi nuovamente in un corpo unico, quello della Nazione. Un corpo da proteggere, tutelare o in casi estremi determinati dalla contingenza degli eventi sacrificare (Sontag, 1989). “Malattia” e “cura” mostrano a questo punto tutto il loro legame con gli orizzonti politici e sociali. Pensare al “corpo della nazione” ci permette di considerare come lo Stato svolga un ruolo centrale nella ridefinizione del concetto di salute. Il “diritto alla salute”, almeno nell’emergenza, diventa il principio cardine all’interno delle narrative politiche e istituzionali. Recentemente rileggendo alcuni passi di Michelle Foucault mi sono ricordato che non è sempre stato effettivamente così. Foucault ci ricorda infatti come questa svolta di un diritto alla salute inteso come nuovo rapporto tra “corpo individuale” e “corpo della nazione” nasca in Europa solamente tra il 1940-1950 con il “Piano Beveridge” per il quale per la prima volta in Gran Bretagna, lo Stato si faceva carico della salute dei cittadini. Questo passaggio risulta incredibilmente curioso se paragonato alle recenti affermazioni del premier inglese.
Nasce quindi una nuova “morale del corpo”, sostiene Foucault in cui lo Stato, termini di diritto è obbligato alla tutela della salute, alla garanzia della cura. Questa nuova morale della difesa del corpo nazionale è talmente forte che nel 1981 l’OMS la trasforma in una delle strategie globali con l’obbiettivo: “Salute per tutti nell’anno duemila”.
Immaginazione. Quell’obbiettivo fallì. E oggi cosa rimane di quella trasformazione? Il contagio trasforma i soggetti nel corpo unico della nazione, ma al contempo svela tutte le contraddizioni che questa nozione porta con sé a livello storico. Cosa ne sta facendo lo Stato del suo corpo? Proprio in questi giorni osserviamo lo svelarsi delle molteplici risposte a questo interrogativo. È ancora presto per trarre un bilancio. Per questo non ho voluto parlare di “stati di eccezione” o di “biopolitica”, sebbene i due concetti ripresi l’uno da Agamben e l’altro dal Foucault rappresentino delle lenti calzanti per l’analisi dei recenti avvenimenti.
Ad oggi l’unica certezza è che questo contagio stia davvero trasformando radicalmente pezzi del mondo che siamo abituati a vivere e pensare. Le certezze quotidiane e culturalmente considerate diventano oggi scenari di pura incertezza. Tra le maglie della sofferenza e del disorientamento che questa situazione produce trova però spazio una nuova facoltà, quella dell’immaginazione.
Abbiamo in questo momento la possibilità di re-immaginare silenziosamente le nostre vite e il sistema in cui sono immerse. La ripartenza sarà dura ma abbiamo tutte le carte per NON tornare alla normalità, bensì costruirne una nuova fondata sull’invito a trovare un nuovo senso per la parola comunità.
23.03.2020
Giacomo Rogora

Foto:
– “La Metamorfosi di Narciso” di Salvador Dalì
– “Metamorphose” di M.C Escher
Per leggere il contributo di Daniele Cassandro su “L’internazionale”: https://www.internazionale.it/opinione/daniele-cassandro/2020/03/22/coronavirus-metafore-guerra
Per leggere i contributi di Giorgio Agamben invece: https://www.quodlibet.it/una-voce-giorgio-agamben