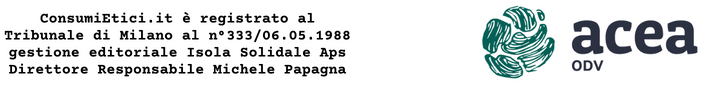“Se il voto di milioni di persone può essere aggirato e messo nel nulla, il disincanto e il distacco dei cittadini cresceranno e crollerà l’affidabilità degli strumenti democratici se una maggioranza parlamentare può impunemente travolgerli…”
La battaglia dell’acqua continua, non è affatto finita con il referendum votato dalla maggioranza assoluta dei cittadini italiani nel 2011.
Non è finita perché continuano i tentativi di stravolgere quella volontà popolare.
La battaglia per l’acqua è strettamente connessa con quella per la democrazia: lo svilimento della sovranità popolare su questo tema contribuisce direttamente ad allontanare le persone dalla responsabilità civica.
Per questo abbiamo deciso di riportare un intervento da uno dei padri della tematica dei beni comuni, a partire dall’acqua: il Prof. Stefano Rodotà.
Cinque anni fa il referendum. La democrazia, i cittadini e le nuove norme sui servizi idrici.
Quasi cinque anni fa, nel giugno 2011, ventisei milioni di italiani votarono sì in un referendum con il quale si stabiliva che l’acqua deve essere pubblica. Oggi, ma non è la prima volta, si cerca di cancellare quel risultato importantissimo, approvando norme che sostanzialmente consegnano ai privati la gestione dei servizi idrici. Non è una questione secondaria, perché si tratta di un bene della vita e perché viene messa in discussione la rilevanza di uno strumento essenziale per l’intervento diretto dei cittadini. Tutto questo avviene in un momento in cui si parla intensamente di referendum sì che, prima di approfondire la questione, conviene dire qualcosa sul contesto nel quale ci troviamo.
Una domanda, prima di tutto. Il 2016 è l’anno del referendum o dei referendum? Da molti mesi si insiste sul referendum autunnale, dal quale dipendono un profondo mutamento del sistema costituzionale e, per esplicita dichiarazione del presidente del Consiglio, la stessa sopravvivenza del governo. Ma nello stesso periodo si sono via via manifestate diverse iniziative dei cittadini per promuovere altri referendum, ma anche per raccogliere firme per presentare leggi di iniziativa popolare e per chiedere che la Corte costituzionale si pronunci sulla legittimità della nuova legge elettorale (e già il Tribunale di Messina ha inviato l’Italicum alla Consulta).

Questo non significa che quest’anno saremo chiamati a pronunciarci su una serie di referendum. Questo avverrà in un solo caso, il 17 aprile, quando si voterà per dire sì o no alle trivellazioni nell’Adriatico. Per gli altri dovremo aspettare il 2017. Ma già dai prossimi giorni cominceranno le diverse raccolte delle firme, con effetti politici che non possono essere trascurati. In un tempo dominato dal distacco tra i cittadini e la politica, dalla progressiva perdita di fiducia nelle istituzioni, questo attivismo testimonia l’esistenza di riserve diffuse di attenzione per grandi e concreti problemi, di mobilitazioni non sollecitate dall’alto che non possono per alcuna ragione essere sottovalutate. Ma non saremo di fronte soltanto ad un inventario di domande sociali. Poiché a ciascuna di queste domande si fa corrispondere una iniziativa istituzionale, questo significa che i cittadini diventano protagonisti della costruzione dell’agenda politica, dell’indicazione di temi di cui governo e Parlamento dovranno occuparsi. Non è un fatto secondario per chi vuole stabilire lo stato di salute della democrazia nel nostro Paese.
Seguiamo i diversi casi in cui si vuol dare voce ai cittadini. Una larga coalizione si è costituita intorno a tre referendum “sociali”, che riguardano lavoro, scuola, ambiente e beni comuni, per abrogare norme di leggi recenti (Jobs act, “buona scuola”) che più fortemente incidono sui diritti. Tre sono pure i referendum istituzionali, poiché a quello sulla riforma costituzionale se ne aggiungono due riguardanti l’Italicum. Le leggi d’iniziativa popolare riguardano l’articolo 81 della Costituzione, il diritto allo studio nell’università (per iniziativa della rete studentesca Link), la disciplina dell’ambiente e dei beni comuni. E bisogna aggiungere l’iniziativa della Cgil che sta consultando tutti i suoi iscritti su una “Carta dei diritti universali del lavoro”, mostrando come si vada opportunamente diffondendo la consapevolezza che vi sono decisioni che bisogna prendere con il coinvolgimento il più largo possibile di tutti gli interessati.
Sarebbe un grave errore archiviare queste indicazioni come se si fosse di fronte ad una elencazione burocratica. Vengono invece poste tre serissime questioni politico-istituzionali: come riaprire i canali di comunicazione tra istituzioni e cittadini, per cercar di restituire a questi la fiducia perduta e avviare così anche una qualche ricostruzione dei contrappesi costituzionali; come evitare che si determini una inflazione referendaria; come riprendere seriamente la riflessione su “ciò che resta della democrazia” (è il titolo del bel libro di Geminello Preterossi da poco pubblicato da Laterza). Ma sarebbe grave anche giungere alla conclusione che l’unico referendum che conta sia quello, sicuramente importantissimo, sulla riforma costituzionale, e che tutti gli altri non meritino alcuna attenzione e che si possa ignorarne gli effetti.
Sembra proprio questa la conclusione alla quale maggioranza e governo sono giunti negli ultimi giorni, nell’approvare le nuove norme sui servizi idrici, che contraddicono il voto referendario del 2011. Quel risultato clamoroso avrebbe dovuto suscitare una particolare attenzione politica e, soprattutto, una interpretazione dei risultati referendari la più aderente alla volontà dei votanti. E invece cominciò subito una guerriglia per vanificare quel risultato, tanto che la Corte costituzionale dovette intervenire nel 2012 con una severa sentenza che dichiarava illegittime norme che cercavano di riprodurre quelle abrogate dal voto popolare. Ora, discutendo proprio una nuova legge in materia, si è prodotta una situazione molto simile e viene ripetuto un argomento già speso in passato, secondo il quale formalmente l’acqua rimane pubblica, essendo variabili solo le sue modalità di gestione. Ma qui, come s’era cercato di spiegare mille volte, il punto chiave è appunto quello della gestione, per la quale le nuove norme e il testo unico sui servizi locali fanno diventare quello pubblico un regime eccezionale e addirittura ripristinano il criterio della “adeguatezza della remunerazione del capitale investito” cancellato dal voto referendario.
È evidente che, se questa operazione andrà in porto, proprio il tentativo di creare occasioni e strumenti propizi ad una rinnovata fiducia dei cittadini verso le istituzioni rischia d’essere vanificato. Se il voto di milioni di persone può essere aggirato e messo nel nulla, il disincanto e il distacco dei cittadini cresceranno e crollerà l’affidabilità degli strumenti democratici se una maggioranza parlamentare può impunemente travolgerli.
Questo, oggi, è un vero punto critico della democrazia italiana, non il rischio di una inflazione referendaria sulla quale Ian Buruma ha richiamato l’attenzione. Le sue preoccupazioni, infatti, riguardano un particolare uso del referendum, populistico e plebiscitario, promosso dall’alto, e dunque l’opposto del referendum per iniziativa dei cittadini, che è il modello adottato dalla Costituzione. I costituenti, una volta di più lungimiranti e accorti, hanno previsto una procedura per il referendum che lo sottrae al rischio di divenire strumento di quel dialogo ravvicinato tra “il capo e la folla” indagato da Gustave Le Bon. E che prevede una separazione tra tempi referendari e tempi della politica, per evitare che questi stravolgano il senso del ricorso a uno strumento così delicato della democrazia diretta.
Anche per questa via, dunque, siamo obbligati ad interrogarci intorno al senso della democrazia nel tempo che stiamo vivendo. Di essa si è talora certificata la fine o si sono segnalate trasformazioni tali da indurre a parlare, ben prima delle recenti sgangherate polemiche, di democrazia “plebiscitaria”, “autoritaria”, “dispotica” (forse la lettura di qualche libro dovrebbe essere richiesta a chi pretende di intervenire nelle discussioni). Per analizzare il concreto funzionamento delle istituzioni credo che non sia più sufficiente parlare di democrazia “in pubblico” e che il moltiplicarsi degli strumenti di intervento quotidiano dovrebbe farci ritenere almeno che la democrazia si è fatta “continua”. Ma forse, se vogliamo indagare il nuovo rapporto tra Parlamento e governo, con il progressivo trasferimento a quest’ultimo di quote crescenti di potere di decisione, questa nuova realtà si coglie meglio parlando, come fa Pierre Rosanvallon, di una “democrazia di appropriazione”, nella quale il mantenimento degli equilibri costituzionali è affidato alla costruzione di istituzioni in cui sia strutturato un ruolo attivo dei cittadini, passaggio necessario per recuperare una “democrazia della fiducia”.

Stefano Rodotà
la Repubblica, 17 Marzo 2016
Stefania Magnisi