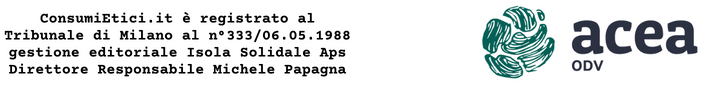Lodi – Festival di Fotografia Etica 2018
Cosa significa “etica”? Scriviamo dalle colonne di una rivista che di questo si occupa da anni dunque è con estrema curiosità che abbiamo visitato un Festival dedicato a quella che possiamo definire una pratica di vita. L’impressione che però ricaviamo camminando tra le opere esposte al Festival di Fotografia Etica di Lodi è quella che il mondo, là fuori, sia brutto in qualsiasi direzione si vada o lo si guardi e che questa bruttezza debba essere esibita. Solo che spesso, a nostro avviso, i risultati attesi con la rilevazione di una immagine del mondo siffatta non vanno più nella direzione di ciò che gli autori presumibilmente intendono veicolare con i loro lavori, vale a dire provocare negli osservatori una reazione, bensì verso l’esatto opposto: li rende assuefatti a quell’orrore che già negli anni Settanta un regista del calibro di Francis Ford Coppola denunciava con il film Apocalypse now. “L’orrore, l’orrore” recitava Marlon Brando nei panni del colonnello Kurtz, un orrore che lo aveva reso lucidissimo e al tempo stesso folle. Di fronte a questo orrore ciò che nella maggior parte dei casi accade è che si chiuda la porta di casa lasciando là fuori il mondo “altro”, quello difficile, che non tocca a noi salvare. Si prova pietà, ci si indigna, si accusa ma non si è disposti ad uscire, si è disposti solo a guardare velocemente passando oltre.
© Marco Gualazzini for AVSI Foundation
Cercare la luce giusta che batte sugli oggetti; ritrarre le cicatrici brutali lasciate sui corpi mutilati; mostrare la ferocia umana sugli animali in una delle pratiche più rivoltanti come quella delle scommesse sulle battaglie tra cani o l’eccidio di massa di altri animali, quelli che vengono allevati intensivamente per soddisfare la vanità dell’alta moda. Decine e decine di altre fotografie come queste che continuano in uno sguardo rivolto esclusivamente a una visione del mondo dettata dalle esigenze di certa stampa che osiamo chiamare “scandalistica”, alla stessa stregua di quella che si occupa di gossip, dove sono i media a decidere le dinamiche di ciò che merita la pubblicazione e con gli autori che si adeguano a colpi di post produzione pur di rientrare nelle specifiche richieste.
© Paolo Marchetti, Il prezzo della vanità
Viene da chiedersi se abbia ancora senso mostrare tante fotografie che narrano l’orrore all’interno di un festival – questo come altri – se la loro esposizione possa ancora essere considerata efficace.
Domenico Quirico, in un testo molto intenso che introduce alla mostra Arma il prossimo tuo, ci chiede di non dimenticare i volti di quegli uomini costretti a morire e uccidere per vivere: “È l’antico terrore, è quella paura degli dei che ha creato gli dei, quella vergognosa paura che sopravvive alla fede stessa” scrive. Ed è ancora la paura che domina nella maggior parte delle immagini esposte, quella che non avvicina gli uomini di quelle immagini a noi e che siamo colpevolmente sollevati di sapere essere lontana dalla porta della nostra casa.
La fotografia fa parte del mondo dell’arte: anche quella di reportage? Dal momento che si mette in mostra e si organizzano attorno ad essa festival e fiere ne fa parte. Quindi, se così è, non è più possibile fruirla nella modalità narrativo/documentaria. Le immagini devono trovare una nuova identità e gli autori devono decidersi a fare i conti con la sottrazione. Nella nostra epoca vi è una tale sovrabbondanza di immagini di attualità, registrate con i milioni di telefoni cellulari esistenti e inviate in tempo reale su ogni tipo di social virtuale, per cui non è più necessario che un autore narri una storia all’interno di un reportage. Guardando questi documentari visuali ci si rende conto che non sono più di cinque o sei le immagini che danno il senso di ciò che si vuole esprimere, tutte le altre fungono da “didascalia descrittiva”, da contorno, oscurando la trasparenza della visione che permetterebbe al fruitore di oltrepassare il visibile, portando la sua attenzione al di là del limite fisico dell’opera, facendolo arrivare “dentro” l’opera stessa. Questo discorso conduce inevitabilmente a saltare la retorica e la forma, ostacoli che non permettono di approdare al vero senso dell’oggetto ritratto, senza veli. Per fare questo bisogna avere il coraggio della rinuncia, essere disposti a eliminare ciò che non supera la prova della reale necessità di compiere un determinato scatto fotografico. Questo deve fare un autore vero.
La necessità di cui si parla qui deve prima di tutto scaturire dall’autore stesso, spesso restio a “tagliare” non rendendosi conto fino in fondo di quali siano le immagini che vanno veramente oltre la soglia della retorica e della bella forma. È oltremodo responsabilità dei curatori e dei photo editor che intendano fare un serio lavoro culturale (anche con il reportage), selezionare proprio quelle immagini che superano il limite del racconto giungendo a parlare al fruitore, a interagire con esso, in una dimensione che lo porti al di là della semplice affermazione: “che bella fotografia” o “che fotografia interessante”, ove troviamo una composizione gradevole e dei colori molto ben post prodotti.
Quasi tutte le mostre presentate agli innumerevoli festival esistenti, e anche il Festival di Fotografia Etica di Lodi non ne è esente, peccano invece di immagini retoriche e formali: belle fotografie che non parlano più se non in termini estetici, anche e soprattutto di fronte alla disgrazia. Nel caso di un festival come questo bisognerebbe provare a definire più nel concreto cosa voglia dire “parlare di etica nella realtà”. Parlare in generale di “realtà”. La fotografia ne è una riproduzione o un’interpretazione? La fotografia deve evocare o semplicemente mostrare? Quesiti fondamentali che bisognerebbe dibattere approfonditamente.
Possiamo provare a esprimere un concetto secondo il quale la fotografia fruita come documento, ha terminato la sua funzione. La cosiddetta “narrazione”, nella formula in cui i photo editor continuano a volerla preservare, non è più efficace perché tale narrazione è inevitabilmente viziata dal compromesso, dalla manipolazione delle informazioni (oltre che delle immagini stesse) e finanche dall’interpretazione autoriale.

© Paula Bronstein, Apolidi, abbandonati e indesiderati: la crisi dei Rohingya
Durante una lectio magistralis tenuta da Letizia Battaglia ad un altro festival, la famosa fotografa palermitana si addentra nel concetto volto a stabilire quando una fotografia è bella per scoprire che lei stessa, dall’alto della sua pluriennale esperienza, non è in grado di stabilirlo. Ecco che il bello viene a cadere e in questo punto possiamo innestare la pratica della rinuncia, una sorta di asciugatura, di sottrazione che, una dopo l’altra, fa cadere quelle immagini superflue, puramente descrittive. Tale pratica forse non porterà a definire un’immagine “bella” ma senza dubbio di essa si potrà dire che è “necessaria”.
Esaminando più nel concreto gli autori esposti nell’edizione 2018 del Festival di Fotografia Etica troviamo poche proposte che vanno in questa direzione – ovvero la sfida alla sottrazione, che non significa soltanto meno fotografie ma soprattutto meno descrizione – immagini in cui la “storia” è percepibile attraverso l’impegno del fruitore nell’osservarle. L’esagerata descrizione è infatti leziosa e non porta il pubblico ad assumere una posizione critica, a chiedersi: cosa sto guardando?
Un esempio di fotografie non descrittive è quello di Filippo Venturi che con la serie Fabbricato in Corea mette a confronto le realtà di due paesi divisi dall’ideologia – la Corea del Sud e quella del Nord – nel suo lavoro mostra immagini esposte le une di fronte alle altre: le fotografie riproducono situazioni simili ma in differenti contesti politici. Al centro della sala una linea di demarcazione (quella del 38° parallelo) introduce lo spettatore al tema di una impossibile attraversabilità di quella linea virtuale, incisa nel paesaggio (anche quello espositivo) che da sola è in grado di far comprendere a chi osserva le differenze tra i due luoghi. Eppure le similitudini tra le due parti sono ugualmente percepibili. Il mondo globalizzato e moderno della Corea del Sud possiede le stesse tradizioni di quello apparentemente statico della Corea del Nord ed è questa unione atavica che lega i due popoli costretti a restare divisi. Il lavoro di Venturi sintetizza così la più ampia divisione tra paesi ricchi e paesi poveri a dividere i quali c’è una linea di confine, una barriera che in molti luoghi è spesso attraversata a rischio della vita, per giungere infine alla dimostrazione che le due metà sono simili, vivono due differenti specie di oppressione: da un lato la schiavitù del consumismo, dall’altro quella dello sfruttamento.

© Filippo Venturi, Fabbricato in Corea|Sogno coreano
Nanna Heitmann, giovane fotografa tedesca, riesce solo parzialmente a centrare il suo obiettivo etico. Anche nel suo caso – ma qui possiamo essere più indulgenti vista la giovane età dell’autrice – il lavoro presentato, Passando dalla finestra – la fine di un’era, è un misto di immagini est-etiche come il volto del minatore coperto di polvere di carbone da cui spuntano due limpidi occhi azzurri (che possiamo anche interpretare come purezza dell’anima, ma non basta), e di immagini enigmatiche che cercano di indurre lo spettatore a entrare nella storia aggiungendo un suo proprio pensiero critico come quella della saponetta bianca poggiata su un piano, saponetta che il minatore di cui sopra utilizzerà per lavarsi a fine lavoro. È bianca, neutra apparentemente non dice nulla. In realtà dice moltissimo, racconta per esempio di come lavarsi dalla fatica non significhi cancellarla, o di come ciò che ci circonda sia così neutro, appunto, da cancellare viceversa la nostra vera identità.
Anche per Tomaso Clavarino, Confiteor (Io confesso), le immagini che meglio entrano nel cuore del tema da lui affrontato – quello della pedofilia di certa curia – le più efficaci, sono quelle che “non mostrano” né l’abusatore né l’abusato bensì gli oggetti, quotidiani, “normali”, che di questi individui parlano molto più che i loro volti. Guardare in faccia il nemico o la vittima non sempre produce la giusta reazione: quella che porta ad avere una posizione critica. Sapere che quell’individuo ha condiviso oggetti ipoteticamente comuni a molti fa viceversa rabbrividire.
In questi tre autori si comprende con evidenza come l’idea che si debba sottrarre sia fondamentale. Sottrarre le immagini, prima di tutto, quelle estetizzanti, quelle didascaliche, quelle descrittive, quelle con effetti a tutti i costi sorprendenti e, in ultimo, ma non meno importante, quelle che servono soltanto a riempire lo spazio. Lo spettatore ha tutti gli strumenti per entrare in una storia, ma occorre che l’autore e il photo editor di turno gli permettano di farlo.
FESTIVAL DELLA FOTOGRAFIA ETICA – LODI 6-28 OTTOBRE 2018
www.festivaldellafotografiaetica.it