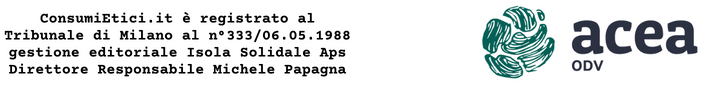Non credibile, poco coerente, scarna nelle risposte, poco circostanziata nel racconto delle violenze subite. E poi ci si domanda, con un alone di sospetto e sottintesa accusa: perché non ha attivato la protezione statale del suo paese?
Insomma, si tratta di una millantatrice che fa la furba, che mente e neppure si è attivata per essere protetta dalla “sua” polizia (poco importa se corrotta o incapace) prima di scomodare le nostre autorità. Una che, diciamolo, non ha veri problemi nel proprio paese dove non è in essere, secondo la Commissione “alcun conflitto”, ma viene qua, con dei sotterfugi a cercare di godere, e dunque a intaccare, la nostra “pacchia”. Una pigra migrante economica.
Con questo lapidario, ma fortunatamente appellabile, giudizio, è stata liquidata la domanda di asilo di una giovane donna nigeriana, che non può neppure permettersi di essere menzionata con il suo vero nome perchè a rischio di ulteriori persecuzioni da parte dei suoi aguzzini.
La chiameremo Hope perchè in fondo è la speranza, ancor più della disperazione, che muove tutte le creature in fuga, il vero pull factor delle migrazioni forzate (ma non diciamolo al ministro dell’inferno se no potrebbe venirgli in mente di abolire anche la speranza per legge così come ha già fatto con l’umanità, prontamente abrogata con il decreto sicurezza)
Hope, che Hope non è, ha iniziato il suo cammino di dolore con uno stupro in Nigeria. Costretta, secondo le leggi tradizionali a sposare il proprio violentatore, ha subito abusi di ogni tipo per tutta la sua vita “matrimoniale” fino a quando, arrivata al limite dell’umana sopportazione, ha trovato il coraggio di fuggire. Ma anche la fuga ha un prezzo. E il prezzo è il suo corpo, la sua intimità e la sua fede. Come molte vittime di tratta; Hope viene sottoposta al rito dello Juju,vale a dire il giuramento, nelle mani dello stregone locale, di restituire il debito contratto con i trafficanti che le garantiranno la fuga e la promessa di non denunciarli mai. Viene spogliata, le vengono strappati peli pubici e ciocche di capelli ed inferti tagli. Un’umiliazione necessaria per imboccare la via della salvezza. Giunta il Libia viene imprigionata e ancora violata fino a quando una barca gremita e malferma la conduce in Italia. Ma il suo debito con la cattiva sorte e con i trafficanti resta da saldare. In Italia viene raggiunta dalle minacce dei suoi “creditori”, dotati di buona memoria ed esperta spietatezza. Le spiegano con metodi convincenti che dovrà prostituirsi per saldare in fretta il proprio debito.
Hope, che Hope non è, in due anni riesce a pagare i primi 2000 euro, ma sa che non riuscirà mai a restituire i 20 mila richiesti se non rinunciando definitivamente alla propria dignità. E allora impara a fidarsi. Si confida con la sua educatrice, si rivolge al centro anti tratta e denuncia i suoi aguzzini violando il giuramento.
Quando un giudice finalmente ascolta il suo racconto, non fatica a comprendere che Hope, che Hope non è, lungi dall’essere una millantatrice, è portatrice di uno dei diritti più sacri, quello ad avere asilo, e le riconosce lo status di rifugiata. Perchè “la situazione delle donne migranti che tornano in Nigeria è senz’altro difficile.. queste non solo devono affrontare le normali difficoltà connesse alla condizione femminile nel loro paese, ma vengono emarginate, in quanto percepite come persone che in qualche modo hanno fallito, non raggiungendo gli obiettivi che si erano proposte con la migrazione in un altro paese. Spesso, inoltre, queste ragazze si trovano a non avere ancora ripagato interamente il debito nei confronti dei trafficanti e ciò le rende estremamente vulnerabili e a rischio di essere nuovamente vittime di traffico di esseri umani.”
Si tratta di un riconoscimento, non di una concessione. Quel diritto Hope lo portava con sè fin da quando è scappata dalla Nigeria e certamente appena è approdata in Italia. Le apparteneva, quel diritto, così come le violenze e il dolore di cui era in qualche modo frutto e conseguenza, ma nessuno, prima di quel giudice, lo aveva saputo riconoscere. E oggi Hope, che Hope non è, potrebbe in effetti chiamarsi speranza.
Alessandra Ballerini
(si ringrazia la Repubblica di Genova, domenica 17/2/19 e Mauro Biani per la vignetta di copertina)