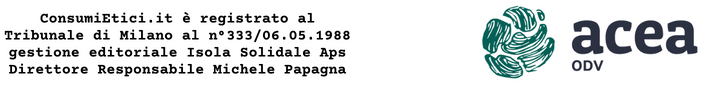Violazioni dei diritti umani.
Una folla immensa di passanti e soccorritori si raccoglie intorno a delle macerie, ai resti di quello che doveva essere un palazzo di dimensioni piuttosto grandi. Mamme e mogli mostrano delle immagini di figli e mariti che evidentemente hanno perso sotto i ruderi. Quanto valevano le loro vite? Circa 6 dollari al mese, se riuscivano a lavorare almeno 13 ore al giorno. Quante vite servono per sfamare uno dei tanti mostri creati dalla moda, e in particolare dalla cosiddetta “fast fashion” (moda “veloce”)?
Quelle descritte sopra sono alcune scene tratte dal documentario “Le ali non sono in vendita” sui lati oscuri del glamour, prodotto da FAIR e promosso da Abiti Puliti; e si riferiscono al crollo del complesso edilizio Rana Plaza del 2013 in Bangladesh, in cui persero la vita 1134 lavoratori. Nel Rana Plaza erano operative tre fabbriche, che producevano indumenti per aziende quali Benetton, Gucci, Versace, Prada, Mango, Primark, Walmart. La velocità a cui le collezioni vengono lanciate sul mercato e le quantità di modelli e capi che inondano i negozi delle città occidentali avevano reso necessario il rischio che quelle vite andassero perse, anche a causa di un ampliamento del palazzo con tre piani ulteriori che si erano dimostrati dopo pochissimo non sicuri.
Come si accennava, i ritmi produttivi dettati da un simile business model di consumo “selvaggio” e bulimico impongono che i diritti umani dei lavoratori di parti del mondo in cui non vigono leggi a loro difesa vengano sistematicamente violati. Sia marchi di alta moda che quelli di moda veloce in occasione della tragedia Rana Plaza si espressero contro le condizioni di semi schiavitù in cui i lavoratori di paesi come il Bangladesh versano e un Accordo ad hoc venne siglato.
Una simile situazione non è il risultato delle sole politiche predatorie dei grandi brand e dei conglomerati di aziende che talvolta li gestiscono. Una gran quantità di potere è di fatti in mano ai consumatori.
Costa meno, dura meno.
Oggi l’industria tessile produce il 400% in più di indumenti rispetto a 20 anni fa, e i brands lanciano 52 micro collezioni al posto delle precedenti due stagioni. Come spesso quando si parla di consumismo, ci si trova di fronte a un circolo vizioso: noi compriamo molti più vestiti perché costano meno, le aziende devono lanciare nuovi trends e produrre maggiori quantità per soddisfare la domanda, e così via. All’origine di tale dinamica probabilmente l’obiettivo di abbattere i costi e indurre volumi di acquisto per singolo individuo in costante crescita con capi di minore qualità, che possono permettersi fasce di popolazione sempre più ampie. Le abitudini dei consumatori sono cambiate drammaticamente negli ultimi due decenni, in favore di capi che costano e durano meno. Le aziende sovra producono per anticipare eventuali successi stratosferici di una determinata collezione.
Qual è la sorte di ciò che non viene acquistato? Fino a poco tempo fa semplicemente veniva dato alle fiamme, non solo per conto di brands come H&M e Zara, bensì anche per quello di diversi luxury brands; in modo che l’immagine dellle collezioni si mantenesse fresca e innovativa.
Ciò che non si compra si brucia.
Nel 2018 è stato divulgato al Wall Street Journal che al termine dello stesso anno finanziario Burberry aveva disposto che circa 38 milioni di dollari in merce invenduta venissero distrutti. Per giustificare il proprio operato, Burberry si impegnò da quel momento a produrre solo ciò che stimava sarebbe stato sicuramente comprato e avviare campagne significative per il riciclo dei tessuti.
H&M non ha mai dato segni di prevedere dei passi indietro rispetto alla produzione in eccesso: sempre nel 2018 il colosso svedese ha annunciato di aver immagazzinato circa 4 miliardi di dollari in invenduto. Larga parte di questa giacenza sarebbe successivamente stata venduta a prezzi scontati. D’altro canto, dal 2013 l’azienda incoraggia il riciclo di indumenti dismessi offrendo sconti a chi aderisce all’iniziativa. Essa provvede all’installazione di pannelli solari come fonte di energia rinnovabile per gli impianti che inaugura.
Impatto ambientale e cambiamento dal basso.
Le Nazioni Unite hanno costituito nel 2019 una Alliance for Sustainable Fashion (Alleanza per una Moda Sostenibile) per contrastare sia gli sprechi di risorse economiche che l’impatto ambientale disastroso della Moda. È infatti stimato che questo settore sia responsabile per il 10% delle emissioni mondiali di gas serra (seconda solo all’industria del petrolio, più dannosa dei trasporti aerei e marittimi) e l’utilizzo di 1.5 trilioni di acqua ogni anno (la coltivazione di cotone ne richiede enormi quantità). Per la fabbricazione di poliestere ogni anno sono necessari 70 milioni di barili di petrolio. Nella maggior parte dei paesi produttori di indumenti, acque tossiche non trattate, risultato del processo di tintura e lavorazione dei tessuti, vengono riversate direttamente nei fiumi, devastando ogni forma di vita acquatica. I dati apocalittici non mancano.
In attesa che anche la Moda si adegui ad alcuni dei Sustainable Development Goals entro il 2030, azzerando la propria blue print, ancora una volta i veri agenti di un cambiamento dal basso sono gli acquirenti. Comportamenti quali prediligere indumenti creati con materiali riciclati e aderire ad una delle numerose iniziative per il riutilizzo di capi dismessi possono rappresentare la differenza.
Mario Daddabbo